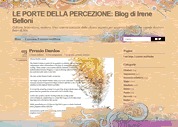Fonte: Centro Studi La Runa
Mi adopererò ora in un’esegesi dell’origine del Cristianesimo che tenga conto, per quanto possibile, della visione della “storia dell’esoterismo”, adottando quindi un punto di vista sintetico senza, spero, perdere il rigore analitico delle precedenti pubblicazioni. In ogni caso, pur tenendo presente interessanti lavori di storici delle religioni, il punto di vista sarà essenzialmente quello esoterico e pertanto si porrà su un piano a cui difficilmente può giungere il semplice ricercatore profano, a cui manca la visione unitario-sintetica.
E’ davvero sorprendente il livello di informazioni rivelatrici che possiamo reperire già dai soli vangeli canonici –sebbene siano fonti già “di parte”- se solo li leggiamo senza traduzioni addomesticate, nella lingua originaria e possibilmente sapendo già cosa cercare.
Analizziamo il fondamento stesso del rito cristiano: l’Eucarestia.
Ora, il pane eucaristico nel testo greco dei vangeli è detto pastikòs cioè pane impastato e lievitato e non azymòs come si direbbe se fosse pane non lievitato. In greco si tratta di due nomi distinti che indicano due distinte specialità alimentari. E’ già sufficiente questo per farci capire che Gesù in privato -e a volte con un certo coraggio anche in pubblico- non seguiva la tradizione biblica.
Infatti il pane del pesach, la pasqua ebraica, è detto matzah e deve essere rigorosamente azzimo.
In questo la Chiesa cattolica si è nettamente riebraicizzata rispetta a quella greco-ortodossa che usa pane non azzimo.
Proseguiamo. Gesù si discosta a tal punto dalla tradizione biblica che intinge il pane eucaristico in qualche genere di intingolo o condimento. Come lo sappiamo? Lo dice lui stesso nell’ultima Cena parlando del traditore: “uno dei dodici, che intinge il pane nel piatto con me mi tradirà” (Marco 14, 20). Ora secondo la tradizione biblica sarebbe una grave blasfemia quella di intingere nel piatto il pane del pesach e condirlo in qualsiasi modo: è una violazione di una delle 613 Mitzvot ebraiche.
Gesù non stava dunque celebrando la pasqua ebraica – se non esteriormente, per non destare sospetti- e non osservava la Legge.
Quale rituale dunque stava celebrando?
Di tutte le comunità più prossime, nel tempo e nello spazio, possono venire in mente solo i Terapeuti d’Egitto del lago di Mareotide, di cui ci dà ragguaglio Filone. Egli riferisce di un pasto sacro che essi celebravano ogni settimo giorno e a base di pane, che poteva essere intinto in essenza di issopo e sale come unico condimento autorizzato (l’issopo è naturalmente associato alla purezza). Inoltre vi era una ricorrenza sacra speciale ogni cinquanta giorni da cui forse il rito della Pentecoste (De vita contemplativa, 75-86).
Le usanze di questo gruppo erano talmente simili a quelle dei primi cristiani che Eusebio di Cesarea nella sua Storia ecclesiastica li classifica come primi monaci cristiani, tanto più che essi seguivano, in parte, delle liturgie ebraiche come lo Shema Yzrael e lo Yozer Or.
I Terapeuti però preesistevano al cristianesimo ed erano, dice Filone, un ramo contemplativo degli Esseni, coi quali condividevano l’essere un gruppo di ebrei pitagorici. Filone riferisce non solo le loro regole etiche di derivazione pitagorea, ma anche la loro dottrina numerologica, di cui ci dà conto circa il simbolismo del 7 e del 50, che egli dimostra partendo dalla dottrina di Pitagora (Legum allegoriae, I, 46). Anche la preghiera del mattino, lo Yotzer Or, stranamente ben si addice alla contemplazione dell’alba di pitagorica memoria.
Per il resto, da quello che dice Filone, l’incidenza della religione ebraica era più legata a fattori esteriori di “appartenenza”, essendo queste confraternite e la loro fondazione del tutto estranee all’usuale tradizione ebraica. Pertanto essi seguivano un dottrinario esoterico di derivazione pitagorica, ed una forma esteriore che si adattava, pur con molte distinzioni, alla tradizione ebraica ma anche ai divieti ascetici dei Pitagorici (essi aborrivano i sacrifici animali di cui il giudeo si dilettava per compiacere il suo dio). Se Gesù era vicino agli Esseni doveva necessariamente essere a parte di queste usanze e, forse, seguirle.
Si tratta certo di ipotesi, legittime, ma solo ipotesi.
Tuttavia, più in generale, rileviamo che il rito del pane e del vino -altro elemento non menzionato finora- non trova riscontro nella tradizione mosaica ed ebraica. Esso invece si trova in un curioso passaggio del Genesi (14,18) ove si parla di Melkisedeq. Questo misterioso sacerdote che già era in Salem quando vi giunse Abramo, vi celebra il rito del pane e del vino, e lo benedice. Tuttavia questa figura è quasi un apax nell’Antico Testamento (ricorre solo un’altra volta, nominato in un salmo). Melkisedeq è un re sacerdote che non ha nulla a che fare con il sacerdozio ebraico, il quale deriva da Aronne, mentre il sacerdozio del Cristo sarebbe originato da Melkisedeq. Questa misteriosa figura non appartiene alla genealogia dei patriarchi, e l’Antico Testamento non ci dice la sua provenienza. Sappiamo solo che non fa parte dei patriarchi del popolo ebraico e che era già lì (in Salem) quando vi giunse Abramo: questo mito indica quindi una indipendenza e una pre-esistenza rispetto alla tradizione ebraica e abramitica. Molto significativamente anche Cristo, sacerdote di Melkisedeq, dice: “prima che Abramo fosse, Io sono” (Gv 8, 58).
Egli rappresenta, possiamo ritenere, una linea di iniziazione più antica della tradizione giudaica, e comunque autonoma rispetto ad essa e che –dato l’uso rituale del pasto sacro di pane e di vino- si connette con la Tradizione Mediterranea, cioè con quel ramo della Tradizione che viene chiamato atlantico-occidentale, rispetto a quello nordico-iperboreo. Sebbene la tradizione ebraica, per il tramite dell’Egitto, abbia avuto dei punti di tangenza con questa Tradizione, soprattutto per ciò che riguarda le sue tradizioni mistiche- tuttavia la religione exoterica vetero-testamentaria è estranea a questa linea sacrale. Il rito del pane e del vino era invece proprio di altre civiltà (alcune delle quali anche semitiche) dell’area mediterranea di cui sopravvisse soprattutto nella forma misterica.
Questa religione primordiale “mediterranea” che coinvolgeva civiltà della Grecia pre-aria, del Medio Oriente e anche della Mesopotamia, senza dimenticare l’Egitto, era spesso incentrata sull’equinozio primaverile quale cardine sacro dell’anno e prevedeva il sacrificio congiunto del pane (Demetra) e del vino (Dioniso). Il pane e il vino, lungi dall’aver solo un significato agricolo-materiale sono invece una forma dell’espressione della forza cosmica nei suoi poli maschile e femminile e sottendono un sacro mistero, che qui si può solo accennare. Sono ovviamente in relazione anche con il Bianco ed il Rosso dell’Opera alchemica. Cloni di questo mito primordiale “mediterraneo” sono la coppia sincretica Dioniso/Demetra o quella babilonese Ishtar/Tammuz, quella Attis/Cibele della Frigia, i cui riti prevedevano non di rado sacrifici di pane e di vino.
Questa vena religiosa dette origine ai culti misterici eleusini, samotraci, frigi e orfici. Essi sono sopravvissuti sino in epoca ellenistica, diffondendosi di nuovo nel Medio Oriente che li aveva prodotti, in quella meravigliosa epoca di sincretismo che furono i secoli I a.C./ II d.C.
Proprio la dottrina orfico-pitagorica, diffusa anche nel mondo ebraico-ellenistico, poté seriamente influenzare quei circoli esoterici citati da Filone. Non è dunque senza precisa connessione col tema di questo articolo che ho rievocato sopra l’ascendenza pitagorica degli Esseni.
Il veicolo di questa diffusione fu di sicuro l’ellenismo.
Un’ulteriore fonte di collegamento può essere stato il regno di Samaria, il quale fu centro di matrimoni misti fra ebrei e popoli ritenuti “gentili” -inizialmente assiri- e di conseguenza di un certo sincretismo religioso, assai mal visto dall’ortodossia ebraica.
Questo processo fu accentuato dalla tendenza, come ricorda Culianu, per cui le religioni misteriche tendono a perdere, durante il periodo ellenistico, l’estensione di tipo tribale, nazionale o regionalistica che ebbero al loro fiorire, per assumere una porta universalistica, spesso favorita dalle campagne militari greche, dato l’alta diffusione di queste religioni esoteriche negli ambienti militari.
Nota caratteristica delle religioni misteriche, spesso rimarchevolmente distanti dai meri culti pubblici o “civili” del paganesimo antico, era che esse miravano ad elevare il miste alla condivisione del destino escatologico della divinità, alla propria immortalizzazione. Esse erano incentrate su una concezione fortemente soteriologica, con preminenza dell’archetipo di un Sotèr divino da incorporare nel miste e che per certi versi rappresentante l’anima stessa del miste, il suo potenziale di divinificazione individuale, in un certo senso il “non io, ma il Cristo in me” di cui dice San Paolo.
La spiga di grano e la vite ad Eleusi – come il pane e il vino di Melkisedeq
Ora è stato proprio un teologo cristiano, Bultmann, a far notare come la forma mitico-simbolica del kerygma cristiano è derivata dalle religioni misteriche il cui elemento veicolante all’interno del cristianesimo fu l’opera di Paolo di Tarso; essa svincolò la figura di Gesù dal modello messianico presentato dal profetismo giudaico (che attendeva una sorta di “re consacrato” ma ristretto al loro nazionalismo religioso, il cui fine era riunire le dodici Tribù disperse e cacciare gli oppressori del popolo ebraico) facendogli assumere invece il carattere del dio-Salvatore dei misteri classici e di molte correnti gnostiche.
Aggiungo personalmente una riflessione: che Gesù il Christo, per le sue caratteristiche storiche non potesse corrispondere al Messia ebraico è facilmente desunto dal fatto che il mashiach per l’ebraismo significa “unto” e questa caratteristica era propria di re e profeti. L’ebraismo attendeva la venuta del prossimo messia (uno dei tanti della sua storia) anche se via via alcune correnti mistiche tesero a connotarlo come una specie di restauratore dello stato edenico (la nostra età dell’oro), tale per esempio si connota nelle profezie di Isaia. Tuttavia rimane l’idea, nelle scritture dell’Antico Testamento, che fosse il soccorritore di Israele. Vi erano molti diversi Messia nell’ebraismo antico; nella tradizione talmudica, si parla di un Messia della tribù di Efrem e uno della tribù di Giuda (discendente di David). Addirittura nello Zohar si sostiene che nasce un potenziale messia in ogni generazione. Inoltre nell’Antico Testamento non si asserisce mai che il Messia possa definirsi un dio-salvatore, né un Dio incarnato, con le caratteristiche cioè del Christo, quale si manifesta nel Cristianesimo.
Anche l’espressione di “figlio dell’Uomo”, nell’AT, si riferisce unicamente ad un essere umano e infatti si traduce generalmente come “uomo”, come in Ezechiele, o indica l’umanità in generale come nei Salmi.
Non c’è un solo passo dell’Antico Testamento che possa far asserire la natura divina del Messia. Questo, nell’AT, è esclusivamente un re consacrato, comunque un essere umano, seppur inviato da Dio; non ha dunque i tratti del Sotèr sovrannaturale.
Del resto non è da stupirsi se Gesù non fu riconosciuto quale messia dagli ebrei del suo tempo.
Nel mio articolo Simon mago era in realtà l’apostolo Paolo? ho evidenziato come una cospicua fetta della Chiesa cristiana orientale del II secolo non riconosceva che Gesù Cristo fosse il Messia annunciato dall’Antico Testamento.
Si consideri poi che, non solo la sua predicazione (anche quella “pubblica”) aveva solamente elementi esteriori di ebraismo, ma anche la sua condizione non fu quella di restauratore della nazione ebraica – non fu mai consacrato re della nazione, né pretese di esserlo: quando il procuratore romano gli chiese se fosse il re dei Giudei, rispose “sei tu che lo dici” – come a dire “è un titolo a cui non tengo e che non rivendico”.
Probabile che qualcuno, lui vivente, lo identificasse col Messia, ma mai Gesù, in nessun passo evangelico, dice esplicitamente di esserlo.
Vi sono invece dei passaggi del “narratore” che in maniera insinuante vuole accostare un qualche miracolo o un qualche segno a dei tratti delle profezie dell’AT. Riguardo ciò, ho già evidenziato nel suddetto articolo, come e perché, secondo l’esegesi di Marcione, sarebbero stati introdotti dei passi nel Nuovo Testamento, per saldare la figura di Gesù con le profezie ebraiche, per soddisfare le aspettative della corrente ebionita (giudeo-cristiana).
Si tratta comunque di un falso storico poiché le scritture ebraiche “canoniche” non sono quelle di una religione universalistica.
Così l’idea dei primi cristiani, di un salvatore divino dalla portata cosmico- planetaria, ha il suo ascendente più prossimo non nel messianismo ebraico, ma semmai nelle profezie zoroastriane dello Shaoshyant o Mithra-Shoshyant.
E di nuovo non può essere un caso se dalla Persia vennero dei Re astrologi ad onorarne la nascita!
Re Maghi. Da notare il berretto frigio delle iniziazioni mithriache e pantaloni di foggia persiana.
Come inciso ricorderei che questi “salvatori divini” (gli shaoshyant zoroastriani) sono l’equivalente degli avatar hindu. Questo conferma l’interpretazione esoterica secondo cui Gesù fu un avatar divino, e spiega l’origine della distinzione gnostica fra un Gesù uomo, l’avatar, il veicolo carnale e temporaneo, e l’Influenza Spirituale discesa su di lui: il Logos-Cristo che in lui si incarnava temporaneamente. La concezione tradizionale del concetto di avatar elimina alla radice le inutili dispute cristologiche su un dogma confuso; confuso perché è la cristallizzazione di una idea tradizionale mal compresa: quella di avatar. Se ci si rifà alle dottrine tradizionali, in particolare all’induismo, che su queste concezioni è di una chiarezza disarmante, si rivelano per prive di senso tutte le dispute cristologiche dei primi secoli.
Con queste premesse andiamo ad esaminare un punto cruciale: Gesù fu condannato come eretico e blasfemo dalle autorità ebraiche. Questo fatto è essenziale: egli non rispettava le norme essenziali di condotta dell’ebraismo, come lo shabat e infrangeva sistematicamente molte regole di purezza. La dottrina che predicava (mi riferisco a quella pubblica, nota attraverso i canonici) non si appoggia se non in minima parte alle scritture del Vecchio Testamento e non cerca di trarre autorevolezza da esso.
Ho evidenziato più sopra che egli non seguisse dei rituali ebraici. Esteriormente si dava l’impressione di celebrare la pasqua ebraica, ma in privato il rito si svolgeva con altre caratteristiche (anche la lavanda dei piedi sarebbe impensabile nel contesto delle leggi di purezza ebraiche).
Io ritengo che Gesù fosse un iniziato ad uno, o forse più d’uno, dei culti misterici orientali dell’era ellenistica, probabilmente accolto all’interno di una delle sette in margine al mondo ebraico. Già abbiamo detto dell’influsso dei misteri pitagorici su Terapeuti ed Esseni e sul modo con cui elementi di entrambe le tradizioni si erano fusi. Il sincretismo nelle sette mistiche di quei secoli era frequente, in Palestina come altrove, e il mondo ebraico, pur ostile ad ogni influsso ellenistico (vedi Maccabei), non sfuggì a questo orientamento.
Ad esempio l’apocalittica giudaica del periodo I a.C. –I d.C. testimonia questa fase rivoluzionaria. Nasce ad esempio un ciclo di apocrifi dell’Antico Testamento come i Libri di Enoch in cui “gli angeli turbolenti” anticipano gli Arconti della Gnosi. In questo gnosticismo di area ebraica nasce la svalutazione del dio dell’Antico Testamento, ormai visto come una potenza minore della creazione e un nemico del genere umano, esempio perfetto: l’Apocalisse di Adamo. La provenienza di questa letteratura è tutt’ora misteriosa e fonte di discussione. Ma questo è l’ambiente che permise il fiorire di un sapere gnostico in Palestina, con un orientamento diametralmente opposto all’ebraismo ortodosso e in cui l’influsso dei misteri orientali del periodo ellenistico è una affascinante storia ancora da esplorare.
Se è difficile ricostruire le vie attraverso cui si diffusero e si fusero queste linee sapienziali di multiforme provenienza, è però più chiaro il punto di arrivo. Gesù doveva far parte di sicuro della setta dei Nazorei (vicina al movimento esseno). Rileviamo come, nei vangeli, vengano nominati tutti i gruppi religiosi ebraici attivi allora in Galilea: sadducei, farisei, zeloti ecc.. non vengono invece mai nominati gli Esseni. Come mai? Forse perché gli apostoli erano loro stessi degli esseni. Quanto alla setta dei Nazareni (altro nome dei Nazorei) essa non solo viene non menzionata nei vangeli canonici, ma addirittura il suo nome viene contraffatto in un toponimo abbastanza controverso, poiché la denominazione Nazareth non ricorre mai nell’AT e, al di fuori dei vangeli, non è attestato se non secoli dopo Cristo. Se vogliamo ammettere comunque che la città di Nazareth esistesse ed avesse quel nome all’epoca di Gesù, rimane un fatto ben strano di natura lessicale: Gesù è detto nazarènos. Se la parola derivasse dal toponimo di Nazareth dovrebbe essere, in greco, nazarethànos.
Anche così i conti non tornano, e si ha l’impressione che qualcuno abbia voluto “nascondere” la filiazione nazorea.
La setta dei Nazorei è quella che ha poi dato origine ai Mandei, i quali ancor oggi si definiscono, nel loro aramaico modificato, Nasurai. Questa setta gnostica e battesimale abbandonò rapidamente la Palestina a causa delle persecuzioni a cui fu sottoposta da parte dell’ortodossia ebraica, persecuzione che avrebbe avuto origine già negli anni 30 del I secolo (secondo l’ipotesi di Schoenfield), e questo trova riscontro nella sorte che toccò sia a Gesù sia a Giovanni Battista, altro profeta nazoreo (stando alla tradizione mandea).
Viceversa, il vangelo dei Nazorei, mostra di appartenere ad ambiente ebionita giudeo-cristiano, senza alcun fondo gnostico, ma questo può essere un fatto assai poco indicativo, dato l’uso di attribuire pseudo epigraficamente questi titoli ai vangeli, a volte senza particolare fondamento.
Comunque va ricordato che stando alle fonti (Epifanio di Salamina, Panarion, 1, 18) i Nazorei seguivano, almeno su certi punti, le usanze e la tradizione ebraica.
L’ostilità e le accuse di blasfemia da parte dell’ortodossia ebraica, la natura gnostica del loro insegnamento (sopravvissuta seppur alterata nella Gnosi mandea), la probabile derivazione da un influsso ellenistico (orfico-pitagorico ma anche egizio, come vedremo più avanti) sono tutti indizi che confermerebbero il fatto che Gesù fosse il maestro di una corrente gnostica che, con un certo sincretismo, veicolava un’iniziazione misterica in un corpo dottrinario esteriore di tipo “ebraico” o che si servisse del linguaggio ebraico per ragioni di “contesto”, ma senza un particolare legame di fondo. L’ebraismo poteva cioè essere una struttura exoterica esteriore, quella del paese di appartenenza, la cui conservazione fosse solo contingente e di facciata.
I Nazorei (concepiti come gli antenati dei Mandei) sono il gruppo che meglio si presterebbe a rispondere a queste caratteristiche.
In ogni caso la pur labile, se non simulata, appartenenza alla religione ebraica, non fu sufficiente a mascherare la natura eretica di questo culto misterico-gnostico, che portò alla condanna per empietà i suoi capi.
I Nazorei antichi sono il gruppo religioso su cui sappiamo di meno, anzi di cui è stata praticamente cancellata ogni traccia, specie negli scritti di autori cristiani dei primi secoli (se si fa eccezione di Epifanio, che però aveva notizie assai superficiali e insoddisfacenti).
A mio avviso si tratta di una omissione tutt’altro che casuale.
Del resto già Guénon circa il cristianesimo dei secoli II e III notò come “tutto ciò che l’aveva preceduto sia stato volontariamente avvolto dall’oscurità” (L’esoterismo cristiano, cap. 2)
* * *
Continua…
Bibliografia ragionata
A.Angelini, La liturgia del pane e del vino 4000 anni fa, Rivista Kemi-Hathor, trimestrale di Alchimia, Spagiria, studi simbolici. Anno XV,n. 81, maggio 1996.
Interessante riflessione circa la connessione fra la Tradizione di Melkisedeq e le antiche civiltà mediterranee.
Questo rito sacrificale del pasto sacro fu di tale diffusione presso gli altri culti misterici che effettivamente molti dei primi cristiani – i quali avevano rapidamente perso ogni idea dell’origine di questa liturgia- si trovarono facilmente disorientati, tanto più che essi avevano mutuato dagli Ebrei un esclusivismo settario che li portò rapidamente a disprezzare i “gentili” e coltivare l’ambizione di soppiantarne il culto. Questo però si scontrò con la somiglianza della loro eucarestia con i riti misterici già esistenti.
Così, è notorio che lo stolido santo e martire Giustino (100-168), giustamente sconcertato dall’evidente corrispondenza con altri riti di pasto sacro a base di pane e vino (o vino+acqua) come quello adottato nella liturgia mithriaca – stante l’incontestabile anteriorità del Mithraismo – non poté far altre che denunciare le trame del Maligno che indussero quegli empi ad imitare, badate bene, anticipandoli, i rituali cristiani! (cfr. Apologia I, § 66, nota 4).
R. Bultmann, Cristianesimo primitivo e religioni antiche, ECIG, Genova 1995
Bultmann, studioso protestante, teorico della “demitizzazione” del messaggio cristiano, da leggere secondo principi ermeneutici alla Heidegger. Secondo ciò egli sostiene che il messaggio cristiano originario è totalmente incomprensibile per l’uomo moderno, incapace di leggerne l’impianto mitico-simbolico, che va appunto denudato e demitizzato. Si può convenire sulla prima parte, non sulla seconda, anche perché la smitizzazione è parte integrante di quel processo che desacralizza le tradizioni, le snatura, ed è peraltro connesso con l’involuzione exoterica.
Il Bultmann ha però il merito di aver riconosciuto il ruolo di ellenizzazione indotto da Paolo di Tarso sul giudeo-cristianesimo. Paolo fu il veicolo non solo della cultura ellenistica ma altresì degli influssi misterici greci e orientali. Il Cristo si svincola così dal prototipo del re messianico del profetismo giudaico ed acquisisce i tratti del Salvatore, proprio alle religioni misteriche pre-cristiane.
Butlmann è stato anche un grande filologo, il primo a teorizzare l’esistenza della fonte Q dei vangeli.
G.G. Stroumsa, La Sapienza nascosta. Tradizioni esoteriche e radici del misticismo cristiano. Ed. Arkeios, Roma 2000
L’autore, docente di religioni comparate, rintraccia la presenza di tradizioni segrete nel cristianesimo e nella Chiesa sin dai suoi esordi, ne traccia la parabola sino alla sparizione a causa della confusione e della avversione che ad esse venne rivolta dai Padri della Chiesa. L’autore ne rintraccia soprattutto l’origine nell’apocalitica giudaica del primo secolo, a mio avviso trascurando forse un po’ troppo l’influsso che può essersi esercitato sullo gnosticismo da parte delle religioni misteriche greche ed asiatiche nonché –soprattutto- dalla sapienza egizia.
L’errore di fondo è nell’insistere sulla natura ebraica dell’esoterismo cristiano: ora, è abbastanza dubbio cosa debba essere l’“esoterismo ebraico”, potendo intendersi per esso, di volta in volta, una interpretazione allegorica della Bibbia (che però è di origine neo-platonica), l’esegesi antinomiana della apocalittica ebraica (che in sostanza è gnosticismo anti-ebraico paradossalmente sorto in ambiente giudaico o aramaico) che però si riduce a dottrine e non a pratiche iniziatiche operative, oppure la via mistica della Merkava, l’unica tecnicamente operativa.
Stroumsa commette un errore di fondo: non comprende che non esiste nessun esoterismo ebraico.
La religione ebraica è anti-esoterica per definizione, anzi essa è il prototipo di tutte le religioni exoteriche (che poi sono solo quelle abramitiche, derivate cioè dall’ebraismo). Come ben sapevano i filosofi antichi anticristiani e antiebraici come Celso o l’ottimo Porfirio, i Giudei non fanno parte delle nazioni sacre: Caldei, Assiri, Egizi, Traci, Samotraci, Eleusini, Frigi, Persiani e Indiani. Celso e Porfirio notavano che gli Ebrei non hanno libri di Teologia (in riferimento alla Bibbia) ma solo elenchi di genealogie, libri storici e leggi morali (tutto questo è exoterismo). Inoltre contestavano che Mosè potesse essere annoverato fra i Prisci Theologi come Orfeo ed Ermete, data l’inconsistenza della sua dottrina sacra (che si riduceva a norme morali, senza teologia). Ironizzavano sui cristiani colti che credevano di intravedere insegnamenti allegorici o addirittura segreti in quegli elenchi di re e fatti storici che è la Bibbia, essendo ovvio per i Greci che una “filosofia occulta” potesse essere decifrata da un mito, ma non certo da un testo storico o di legislazione. Testi del genere sono da intendersi solo in senso piano, non avendo alcun senso la pretesa di una lettura simbolica. Pertanto la pretesa di un esoterismo ebraico fondata sul canone dell’Antico Testamento è cosa ben ardua. Lo conferma il fatto che i rabbini cabalisti dei secoli successivi non poterono far altro che inventare permutazioni combinatorie sulla Torah per giustificare le loro dottrine eterodosse ed eretiche, più volte condannate dall’ortodossia ebraica perché in contrasto con la Legge. Del resto la stessa gematrìa cabalistica è di origine caldea, più che ebraica.
Il sistema magico della Cabala non è altro che la tradizione segreta della magia sacerdotale egizia: le 22 lettere dell’alfabeto ebraico derivano dal sistema magico egizio che impiegava le lettere dell’alfabeto demotico corrispondenti ai 22 nomoi dell’Egitto. Quanto alla tradizione della Merkavah, basata sulla visione di Ezechiele, indica un percorso mistico che è comune a tutti i popoli; il simbolismo specifico del tetramorfo della visione di Ezechiele, con precisi significati astrologici, è in realtà derivato dalla sfinge simbolica degli egizi e dei greci. Anche la teurgia degli angeli è di origine pagana e non ebraica: i geni alati erano caldeo-babilonesi. I nomi di angeli e arcangeli provengono dalla tradizione magica babilonese e questo furono gli ebrei intellettualmente più onesti a riconoscerlo, come il Rabbi Shimon bar Lakish del III sec. d.C.
Sicché si vede che, se non si vuole restringere l’esoterismo a qualche leggera “esegesi allegorica” che lascia inalterato lo status spirituale del miste, ci si deve rifare alla nozione operativa dei misteri e delle iniziazioni. In questo caso la tradizione ebraica non ne ebbe di proprie ma le derivo da civiltà pre-esistenti e più evolute.
Ma sembra che lo Stroumsa non tenga in gran conto l’esoterismo vero, quello operativo, ma che ritenga di doversi limitare a parlare delle “dottrine segrete”, cosa peraltro assolutamente priva di senso, perché in tutte le latitudini non sono mai esistite – presso strutture autenticamente esoteriche – dottrine segrete scollegate dall’operatività. Al contrario semmai la natura ineffabile delle verità superiori ha limitato la possibilità di codificare sistemi dottrinari complessi- aspirazione peraltro unicamente moderna- ma ha privilegiato il momento “esperienziale”. Le verità del simbolo non possono essere esaurite da un linguaggio discorsivo ma dalla loro esperienza diretta, come già disse Platone nella VI lettera. Il resto è speculazione teologica, non esoterismo.
Stroumsa prende per “esoterismo ebraico” un insieme di testi religiosi eterodossi ma che davvero segreti non erano: dal momento che furono scritti e destinati alla circolazione pubblica o semipubblica.
Al massimo si può parlare di un letteratura eterodossa.
Insomma il suo libro, di un centinaio di pagine, non smentisce affatto la matrice ellenistico-misterica o egizia del Cristianesimo segreto. Piuttosto l’Autore dovrebbe riconsiderare non solo la sua nozione imprecisa di “esoterismo” ma anche riflettere sull’origine non-ebraica dei sistemi autenticamente esoterici diffusi nel mondo ebraico.
Inoltre la sua distinzione fra un mistero sul rito (tipico dei pagani greci ed egizi) e un mistero sulla dottrina (tipico dell’ebraicità) è pura fantasia. Ce lo conferma il fatto che conosciamo ormai bene la dottrina della letteratura apocrifa ebraica, che evidentemente non era poi così segreta, laddove i greci difesero fino alla morte il segreto dei rituali misterici, su cui sappiamo quasi nulla.
A smentire questa impostazione vale notare che il cristianesimo gnostico aveva un corposo apparato di rituali e “parole di potenza” difese dal segreto più completo. Mentre gli gnostici divulgarono tranquillamente la loro dottrina, o almeno buona parte di essa, sotto forma mitologica.
Basterà poi ricordare che quello degli gnostici era esattamente un “ebraismo” alla rovescia, un anti-ebraismo.
E.Noffke, Introduzione alla letteratura medio giudaica precristiana, Claudiana, Torino, 2004.
Per gli influssi ellenistici sulla produzione teologica ebraica.
H. Schonfield, Pentecost Revolution, TBS The Book Service Ltd, 1974.
Una interessante teoria che identifica i primi cristiani con i Nazorei o Nazareni. Tuttavia l’autore sembra perdere di vista il contenuto gnostico della setta, mentre li identifica con gli ebioniti giudeo-cristiani.
Parte II
di Musashi
Fonte: Centro Studi La Runa
Ho scritto della connessione di Gesù con la setta eterodossa dei Nazorei (da non confondere col voto di nazireato, che invece rientrava negli usi dell’ebraismo ortodosso antico).
La sopravvivenza di questi Nazorei nell’attuale setta gnostica dei Mandei dell’Iraq, parlanti in effetti un dialetto aramaico (fatto attestante la loro origine palestinese), potrebbe confermare che Gesù fosse a capo di una setta gnostica perseguitata per questo dai sacerdoti ebrei.
Quanto all’influsso di una qualche forma di iniziazione sul prototipo dei misteri ellenistico-orientali è però soprattutto a indizi tratti dal lessico protocristiano che dobbiamo guardare.
Ad usare il termine greco mysterion è proprio san Paolo. Vero è che questa parola ricorre già nel greco della Bibbia dei Septuaginta, ma essa è centrale solo nella teologia paolina e, nelle lettere di Paolo, ricorre almeno ventuno volte, quasi più che in tutti i libri del Vecchio Testamento. Unica parziale eccezione in contesto ebraico è la letteratura apocalittica che produsse gli apocrifi ebraici dell’Antico Testamento dove la parola equivalente è l’ebraico raz, appunto la rivelazione (apocalypsis) di un mistero divino. Ma sappiamo già la natura gnostica o pre-gnostica di questa letteratura ebraica “revisionista” e anti-giudaica.
Verrebbe allora da estendere la riflessione a quanta parte ebbe l’influsso misterico-ellenistico in questa evoluzione del pensiero religioso giudaico, anche in considerazione che la parte più colta e rilevante degli ebrei della prima diaspora viveva – già all’epoca di Cristo – ad Alessandria, ambiente greco-egiziano, e dovette assai riconsiderare la fede dei Padri alla luce delle filosofie ellenistiche (vedasi il pensiero di Filone e la sua esegesi allegorico-platonica della Bibbia).
Così vediamo che il termine mysterion (o il suo equivalente ebraico) è proprio ad una categoria di testi religiosi già pre-gnostici (libri di Enoch) o decisamente gnostici e antinomiani (Apocalisse di Adamo), che ormai di ebraico hanno solamente il retroterra mitologico di riferimento (personaggi dell’AT) ma che tecnicamente sono già anti-ebraici.
In Paolo tuttavia l’accento è ancora più significativo perché per lui l’essenza stessa del Kerygma cristiano è associata alla parola mysterion.
Vi sono però altri termini a cui dobbiamo badare e che sono ancora più rivelatori.
A sottolineare infatti la connessione con il mondo delle religioni misteriche ellenistico-orientali, va notato che anticamente Gesù, nei primissimi circoli cristiani, veniva chiamato “Chrestòs”. I cristiani nel primo secolo erano indifferentemente designati sia come “christiani” che “chrestiani”, come ha ricostruito il Lampe (Christians at Rome in the First Two Centuries, P. Lampe 2003), ed altri storici attestano come questa denominazione, derivata da “Chrestòs”, fosse ancora in uso sin nel II secolo (Van Voorst, Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence, 2000 Eerdmans Publishing pagg. 33-35).
Il termine Cristiani ricorre solo tre volte negli Atti degli Apostoli: il testo greco del Codex sinaiticus, risalente al IV secolo, attesta quei termini, in tutte e tre i casi, come “chrestianoi”.
Anche Svetonio parlando del grande incendio di Roma e delle persecuzioni neroniane parla dei seguaci di un certo Chrestos (Vita dei Cesari- Claudio, XXV). Che questa non sia una semplice imprecisione di Svetonio, o un errore di trascrizione, lo attesta anche un passo di Tacito (Annali, XV,44) in cui parla della setta dei Chrestiani, il cui fondatore era un certo Cristo (quindi si usavano i due termini senza molte distinzioni) crocifisso in Galilea sotto Tiberio.
Un’antica iscrizione risalente al 318, in Siria, all’ingresso di uno dei più antichi luoghi di culto cristiani, appartenente ai seguaci di Marcione, riporta la dedica al “Signore e Salvatore Gesù il Chrestòs”.
Anche nei testi manichei, Mani si definisce “Apostolo di Gesù Chrestos”. (Gardner, Lieu manichean texts, pag 167).
Qual è la differenza dei due termini?
Christos (= unto) è la parola greca per l’ebraico mashiach, ed era il titolo impiegato da coloro che pensavano che Gesù fosse il Messia del giudaismo. Chrestòs (dal greco chraomai) è invece un termine tecnico che inerisce al mondo delle iniziazioni ai misteri pagani (orfici, eleusini, bacchici, cabiri), dove indicava la distruzione della natura inferiore, il raggiungimento dello stato di immortalità individuale, il termine cioè dei Piccoli Misteri. Esotericamente si riferisce a colui che è passato per la seconda nascita, che ha eternalizzato sé stesso nel proprio agathodaimon, genio individuale. Tale termine corrisponde esattamente all’egiziano unnefer (“sempre fiorente”), nei misteri egiziani; Osiride era unnefer parola che in greco, come ad esempio fa Plutarco, viene tradotto appunto con “Chrestòs”. Attraverso l’ellenismo infatti il termine passò a designare l’adepto realizzato anche di altri misteri (egizi, caldei ecc.).
Vi sono altri significati che distinguono Chrestos da Christos, termine peraltro del tutto legittimo nel suo ambito, tuttavia questi altri significati non possono essere del tutto svelati qui. Contrariamente a quanti ritengono che lo Gnosticismo sia una linea ormai esaurita, si tratta di un eggregore ancora attivo ed operante, per cui non sono autorizzato a svelare altri aspetti di questa duplice terminologia.
Tuttavia quanto detto è sufficiente per chiarire questa parte del problema: anche questi riferimenti indicherebbero, in modo abbastanza chiaro, la connessione di Gesù con una linea di trasmissione iniziatica di tipo misterico, appartenente al mondo sincretico ellenistico di quel tempo (nel che andrebbe inclusa però anche l’iniziazione egizia).
Tuttavia il progressivo abbandono dell’un termine in favore dell’altro, Christòs, fu opera non casuale di sostituzione, da parte di quella corrente proto-ortodossa che recepì le istanze dei gruppi giudaici di cui al mio precedente articolo (sia chiaro che la nuova religione viaggiava da una città all’altra anche e soprattutto attraverso le comunità ebraiche che vi risiedevano). Poiché in seguito i redattori dei testi furono esclusivamente i seguaci dell’ortodossia, i copisti, vuoi anche solo per ignoranza, cambiarono ogni qualvolta occorreva, la designazione di Chrestòs in Christòs.
Si badi che la soppressione del termine chrestòs va significativamente di pari passo con la soppressione della struttura iniziatica del cristianesimo e più o meno vi coincide anche temporalmente.
Se vogliamo cercare allora le tracce di questa iniziazione misterica, possiamo seguire poche piste ma io indicherei proprio quella meno “appariscente” e in fondo la più bistratta.
Analizziamo quindi il filone gnostico cristiano che rientra in quell’insieme di correnti, generalmente dette “ofite” (fra di esse sono annoverati Naasseni, Peratei, Sethiani), che di solito non hanno riscontrata la giusta attenzione e sono considerate una forma di gnosticismo meno raffinato (se confrontato coi sistemi di Basilide e Valentino).
Si tratta però di una corrente assai antica, tanto che anche negli scritti dei Padri l’origine di questo gruppo si perde nelle brume delle stesse origini cristiane, al punto che nessuno riuscì a risalire a qualche fondatore storico di questo filone. Ai fini della nostra ricerca questo è un elemento positivo, poiché non si lascia ricondurre a nessun fondatore umano, ma la sua origine si confonde perciò con quella dello stesso Cristianesimo generale.
In secondo luogo è necessario per noi rintracciare un filone che sia visibilmente “pagano” cioè non-ebraico (e in effetti il simbolismo del serpente è raro nell’ebraismo e ricorre al massimo tre volte nell’AT). Per contro il simbolismo ofita del serpente era frequente in molte religioni misteriche.
La matrice pagano-gentile degli Ofiti si rivela anche in certi particolari: nella ricostruzione della Genesi biblica contenuta del Libro di Baruch di Giustino, è detto che l’Eone salvifico, il Baruch si rivela a Gesù, ma anche ad Eracle presso i Greci. Un testo ofita, citato da Ippolito di Roma, enuncia l’identità della dottrina segreta di Gesù coi misteri frigi, assiri, samotraci, greci (eleusini ed orfici). Vi si legge: “presso gli Egizi, l’Acqua di vita (=Cristo) è detta Osiride”.
Questo documento, una rielaborazione cristiana di un’elaborazione ebraica di un inno dei misteri di epoca ellenistica, identifica bene a mio avviso la linea di formazione dei “misteri cristiani”: da religioni ellenistico-pagane, passando per gruppi eterodossi ebraici, fino a Gesù e Giovanni Battista.
Del resto la prassi era accettata anche dai Padri della Chiesa: essi ritennero come ispirati i Libri sibillini, cioè un rimaneggiamento cristiano di un’elaborazione ebraica su fonti pagane.
In realtà, costoro raramente e difficilmente si definivano “Ofiti”, ma si riferivano a sé stessi semplicemente come “gnostici”. Il termine sembra sia stato impiegato polemicamente dagli eresiologi, da Ireneo in poi, per farne quasi degli “adoratori del Serpente”, in realtà accentuando pretestuosamente degli aspetti assai marginali del simbolismo o della dottrina. Ippolito li identifica come Naasseni (da nhsh, ebr. “serpente”). A queste correnti sono da ricondurre fra l’altro l’Ipostasi degli Arconti, L’apocrifo di Giovanni, le tre steli di Seth. La produzione di questi testi gnostici mette in risalto il ruolo arcontico del dio dell’Eden che impedisce l’accesso alla Conoscenza, l’Albero (si badi che in molti sistemi simbolici tradizionali è compito dell’eroe impossessarsi lottando dell’ “albero”, che è Potere e Conoscenza, facendo per così dire “violenza al Regno dei Cieli”, violenza che inizia dai tempi dei maestri gnostici: da Giovanni Battista e Gesù in poi. cfr. Mt 11, 12).
Naturalmente il senso del simbolo è sempre duplice. Positivo e negativo.
Il serpente rappresenta un potere primordiale: è Conoscenza ma il suo mancato adempimento comporta una caduta. Come il suo secreto, esso può essere veleno e farmaco.
Il potere primordiale che rappresenta è anche cosmogonico (serpente cosmico): in questo senso esso rappresenta pure il potere sessuale. Assommando in sé l’elemento sapienziale e sessuale, esso rivela il significato occulto dell’uso biblico del termine “conoscere” per indicare l’atto sessuale. In esso si cela l’uso tipico che viene dalla Tradizione e si manifesta in tutte le religioni antiche di associare la tecnica ierogamia (sesso sacro) all’ascesa a stati divini.
Però, per l’ebraismo, l’unica possibilità interpretativa per questo simbolo è esclusivamente svalutativa, ne contempla cioè unicamente gli aspetti negativi, ignorandone le possibilità iniziatiche, anzi proibendole (Gen. 2,16-17). Ma la religione ebraica è l’origine delle tradizioni exoteriche in sé stesse nemiche e avversarie dell’esoterismo. Così l’elenco delle proibizioni verso l’Albero della Conoscenza, e verso l’atto del “conoscere” (sesso iniziatico) rivelano la natura anti-gnostica dell’ebraismo. Lo stesso uso del sesso a fini procreativi, e solo per quelli, serviva alle potenze occulte che hanno ispirato l’antica religione ebraica ad impedire la ierogamia, praticata invece dagli antichi collegi di sacerdoti e sacerdotesse (egizi, caldei, fenici, babilonesi, assiri..). Scrive Evola: “la visione prevalentemente lunare del sacro […] ha stigmatizzato come luciferico non solo ciò che realmente è tale ma anche ogni tentativo di reintegrazione tipo “eroico” e ogni spiritualità estranea ai rapporti di devozione e di creaturale dipendenza dal divino teisticamente concepito” (Il Mistero del Graal pag.102).
Per la verità gli Ofiti sembrerebbero rifarsi soprattutto alla vicenda mosaica del serpente di bronzo, forti dell’analogia Cristo/Serpente annunciata dal vangelo giovanneo.
Circa la relazione Cristo-Serpente fu il gruppo gnostico dei Perati (corrente affine ai Sethaini e ai Naasseni) a sostenere una interessante ipotesi di carattere astrologico. Per essi, il Cristo era un Logos emanante dalla costellazione del Draco (Ippolito., Ref. V.17-19). Questa è una tesi ardita ma assai plausibile in sé, in quanto quella del Draco è una costellazione circumpolare e, circa 2800 anni fa, la stella polare coincideva esattamente con la stella Thuban (α Draconis). Ora, se consideriamo la correlazione Cristo-Stella polare, il cerchio si chiude. Per i Perati la correlazione non era solo di tipo simbolico ma doveva avere un significato cosmologico reale.
Negli scritti di queste correnti peraltro non sempre il serpente del Genesi è visto come emanazione del Dio Altissimo. Sempre alcuni di essi, ad esempio il Libro di Baruch dello gnostico Giustino, si rifanno invece all’accezione negativa del serpente , visto come desiderio sessuale.
Ma in effetti l’importanza del serpente nei sistemi di queste scuole è chiaramente stata enfatizzata strumentalmente dagli eresiologi del II e III secolo.
Il nostro interesse per essi è di natura ermeneutica: dobbiamo chiederci – se avessero davvero una origine precristiana, per certi versi pagana come si afferma spesso – come mai essi si siano introdotti nel Cristianesimo. E pensare ad esempio che il filosofo pagano Celso (II secolo), nel suo Alethès Logos, come ci dà notizia Origene, non faceva distinzioni fra Ofiti e Cristiani: quindi essi dovevano risultare, a un osservatore esterno, come indiscernibilmente legati. Come è stato possibile che una corrente esogena, assolutamente estranea al Cristianesimo, vi si sia inserita senza problemi?
…E’ evidente che essa doveva essere presente sin dai tempi apostolici. Chi afferma il contrario ha l’onere probatorio di spiegare quando e in quale modo sia avvenuto questo “travaso di paganesimo”.
Se invece assumiamo l’origine del Cristianesimo da un fondo, se non propriamente pagano, almeno da una vena misterico-sincretica con influssi pagani (e vedremo quali), presente ai margini dell’ebraismo ortodosso, il tutto diventa non solo spiegabile ma addirittura prevedibile. Già scrissi, tuttavia, della presenza di una forte componente giudeo-cristiana del tutto priva di sensibilità esoterica, nella gran massa dei convertiti, e questo spiega la necessità di combattere tali aspetti eterodossi, o peggio ancora gentili, incomprensibili a molti giudei.
In questa mia ipotesi exoterismo ed esoterismo era presenti contemporaneamente alla nascita del Cristianesimo e, a causa della presenza di ebrei convertiti, l’attrito fu inevitabile sin dalle origini.
In questa chiave si spiega tutto: si spiega come sia potuto nascere lo gnosticismo all’interno del Cristianesimo; si spiega perché tutti i dottori gnostici rivendicassero una trasmissione apostolica (Valentino fu discepolo di Teudas, discepolo di San Paolo; Basilide fu discepolo di Glaucia, interprete di Pietro e rivendicava una tradizione segreta di Mattia apostolo). Valentino nel 160 arrivò quasi al soglio pontificio. Lo Gnosticismo non poteva essere un fenomeno esterno al Cristianesimo. E’ il Cristianesimo che finì per diventare lo snaturamento in senso exoterico della Gnosi del Cristo. Solo se assumiamo la natura gnostica del Cristianesimo originario possiamo spiegare come mai tre quarti della produzione letteraria cristiana dei primi secoli fosse gnostica. E perché i cristiani gnostici in molte province fossero la maggioranza.
Teuth col doppio ureo porge ad Osiride la chiave di vita.
Ora, a conferma di ciò che espongo vorrei far rilevare delle forme residuali di questa antica forma “ofitica” di cristianesimo, che doveva –nella mia ipotesi- essere quella originale. Nelle liturgie armena, greco-ortodossa, etiope e copta (cioè quelle non intaccate dalla nefasta patristica cattolico-romana), simboli del grado episcopale sono il crocifisso e uno strano pastorale (pataritsa, in greco moderno) con due serpenti, assolutamente inspiegabile rifacendosi alla teologia convenzionale. Questo si trova persino in una congregazione cattolica, ma di origine armena, i cosiddetti mechitaristi. Questo simbolo non ha ovviamente nessuna ragion d’essere nel cristianesimo quale ci è stato tramandato.
Esso risale all’antico Egitto, al Doppio Ureo, simbolizzante la duplicità cosmica della forza serpentina. I due serpenti posti a guardia del Disco Solare alato, sono le dee Nekbet e Uadjet, recanti la corona, una dell’Alto, l’altra del Basso Egitto, anche essi rappresentanti della dualità cosmica. Il doppio ureo di Toth è poi passato nel caduceo di Hermes…o su quello di Cristo!
Anche il simbolo del biblico serpente di bronzo attorcigliato su una croce a “tau”, ricorda il simbolo ankh o chiave di vita dell’Egitto antico.
Ma perché tutto questo dovrebbe interessare lo storico del Cristianesimo?
Ci sono due fatti a dir poco misteriosi che riguardano gli scritti di uno dei Padri della Chiesa, il nemico degli gnostici Sant’Ippolito.
Nel 1840 circa, veniva rinvenuto per la prima volta sul Monte Athos l’unico esemplare rimasto in Europa della sua opera, i Philosophumena. Nei libri II e III di tale opera, afferma di rivelare i Misteri di queste scuole (Naasseni e Peratei). Sarebbe stato davvero un gran colpo per la corrente “proto cattolica” che lui rappresentava.
E invece questi due “capitoli” sono stati inspiegabilmente fatti sparire dal manoscritto! Perché?
Forse erano troppo simili a certi rituali che tanti altri gruppi cristiani proto-cattolici, anch’essi segretamente, praticavano… talché non si volle divulgare un così compromettente segreto?
Certo i cattolici avrebbero avuto tutto l’interesse a denunciare le scellerate pratiche di quegli eretici.
Forse non volevano “mostrare” delle dottrine o dei rituali che quelle scuole condividevano, tutto sommato, con gruppi interni alla Chiesa.
Inoltre, più avanti nella sua opera, parlando di una dottrina dei Peratei che rimandava a delle relazioni occulte di tipo “tantrico” con i centri del corpo umano, per cui il Padre corrisponde al cervello, il Figlio al midollo spinale e la Materia (probabile terzo elemento della Trinità) allo sperma (del resto “il corpo è tempio dello Spirito Santo”), si interrompe bruscamente dicendo di non voler commettere una “profanazione rivelando questi misteri”. ….E perché mai?
E’ davvero ben strano per un eresiologo usare argomenti da iniziato. Se fossero dottrine eretiche e diaboliche perché mai coprirle di segreto iniziatico? Così facendo si è tradito. Evidentemente, se Ippolito usa questa strana cautela è perché nelle dottrine di questi Ofiti vi era una tradizione segreta che, almeno anche solo in parte, molti vescovi cattolici detenevano e custodivano, e Ippolito ne era a parte, ed egli stesso iniziato.
Continua….
Bibliografia ragionata
M.V. Cerutti Antropologia e apocalittica, L’Erma di Bretschneider, Roma 1990.
La letteratura ebraica apocalittica e gli apocrifi dell’Antico testamento, annunciano una mutata visione, assai diversa dalla religione mosaica, e fortemente anticipatrice dei temi gnostici. Gli “angeli turbolenti” di Enoch prefigurano gli arconti della creazione materiale, così come gli accoppiamenti con donne mortali -che generano esseri titanici semidivini – annunciano lo stupro da parte di Yaldabaoth su Eva che darà la nascita ai due dei ebraici Elohim e Jahve quale viene narrato nell’Apocrifo di Giovanni.
L. Moraldi, Le Apocalissi Gnostiche, Adelphi, Milano 1987.
In particolare leggasi “l’Apocalisse di Adamo”, apocrifo dell’Antico Testamento. Si tratta di un testo gnostico ebraico, piuttosto che cristiano gnostico dato che non identifica il Salvatore in Cristo, e probabilmente è stato scritto nel I.sec.a.C. .
Esso riporta una versione assai alternativa e presentata come “segreta” (apocalypsis) del racconto biblico.
Adamo è un essere celeste, un eone del Pleroma (l’Adamas di altri sistemi gnostici o l’Adam Qadmon della Cabala) ma esso viene ingannato da un dio minore il demiurgo Yahwe che gli genera un corpo di materia grossolana determinandone la caduta dallo stato di androgina divina (separazione da Eva, vista come la parte pneumatica). Tutta la storia biblica dei patriarchi è vista come la lotta fra le potenze del Demiurgo e quelle del Dio supremo. Seth terzo figlio di Adamo ed Eva è quello in cui la Sophia riversa tutto la sua luce. La sua discendenza sarà quella degli uomini pneumatici. Il demiurgo ispira i patriarchi ad adorarlo e a “non avere altro di al fuori di lui” ma quando si accorge che c’è una generazione di uomini che non deriva da lui ma è pneumatica, fa di tutto per distruggerli. Manda così il diluvio salvando solo i suoi, facendo giurare a Noè che tutti i suoi figli adoreranno solo lui. Noè ovviamente impone questo giuramento ai figli. I discendenti di Seth sono salvati però dall’intervento di eoni del Dio altissimo: Abraxas, Sablo e Gamaliel.
Fra i discendenti di Noè, molti di quelli che derivano da Jafet e Cam, si uniscono agli uomini pneumatici. Solo Sem rimase totalmente fedele all’Arconte e infatti dalla tenda dei semiti, viene detto, nessuno raggiungerà la Gnosi. Si annuncia poi l’intervento di un salvatore o meglio di un Illuminatore (fostèr).
Se il capo di una setta avesse anche solo in privato sostenuto la metà di questi insegnamenti avrebbe più che meritato la crocifissione per le élite sacerdotali ebraiche. Questo tipo di dottrine confluì poi nella gnosi cristiana in testi come l’Apocrifo di Giovanni.
Van Voorst, Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence, 2000 Eerdmans Publishing.
L’autore dedica alcuni passaggi alla ricostruzione delle fonti sia cristiane sia non cristiane, eterodosse o ortodosse, al di fuori del Nuovo Testamento. Attesta l’uso frequente di Gesù quale Chrestos.
Nel libro viene sfatato il mito, sorto da una interpretazione errata di Svetonio, secondo cui i “Giudei” perseguitati sotto Nerone sarebbero stati istigati da tal Cresto, inteso come il nome proprio di un oscuro personaggio. Cresto non era affatto un nome ebraico, e del resto la diffusione di questo nome fra gli schiavi greci non sembra particolarmente frequente, né attestata dalle fonti del tempo.
Il testo è soprattutto volto a mostrare l’esistenza storica del personaggio Gesù attraverso fonti non cristiane e quindi non di parte.
L.Charboneau-Lassay Il Bestiario del Cristo, Ed. Arkeios, Roma 1994.
Qui lo Charboneau-Lassay, ottimo conoscitore del simbolismo dell’arte cristiana “ortodossa”, difetta invece su quella del cristianesimo gnostico. Come ricordato sopra, per gli gnostici il serpente può anche avere accezione simbolica negativa. E’ il caso specifico del serpente leontocefalo raffigurato in alcuni reperti dei primi secoli. Secondo Charboneau-Lassay sarebbe un simbolo di Iao, il Dio supremo (op. cit. pag.413). Tuttavia questo è abbastanza scorretto poiché sappiamo che tale rappresentazione è tipica invece di Yaldabaoth il sommo arconte. Tale è infatti descritto nell’Apocrifo di Giovanni (10, 10-11) ed anche nella Pistis Sophia (66, 137) che parla di un potere arcontico dalla faccia di leone, uno di aspetto di serpente ed un altro di basilisco. Lo Charboneau-Lassay accosta questa immagine allo Knoumis o Knoubis egizio. Il che è corretto, ma anche qui non si tiene nel debito conto che questa divinità dell’Egitto tardo rappresenta una ipostasi del Demiurgo (e infatti già lo Khnum dell’Antico Regno aveva il ruolo effettivo di edificatore), cosicché dobbiamo di nuovo riferirci ad un arconte o ad un dio demiurgico. Pertanto quel tipo di iconografia del serpente, presso gli gnostici, doveva in tale caso avere accezione nefasta, e non positiva come erroneamente opina lo Charboneau-Lassay. Gli gnostici esecravano in genere il potere del serpente leontocefalo come arcontico, e questo vale anche per coloro che adottavano il serpente quale simbolo di Sapienza, come i Sethiani. Purtroppo il cattolico Charboneau-Lassay attribuisce proprio ai Sethiani il culto di questa figura, tuttavia l’Apocrifo di Giovanni da cui ho tratto la citazione è, sfortunatamente, proprio uno scritto usato dalla corrente sethiana!
Il che smentisce completamente anche questa specifica affermazione dell’Autore. A sua parziale discolpa, va però ammesso che i testi dei Sethiani non erano disponibili prima dei ritrovamenti di Nag Hammadi. Tuttavia va rilevata l’estrema leggerezza di questo autore che dà credito incondizionato a tutto ciò che scrivono i Padri come Tertulliano, i quali avevano la prassi sistematica di attribuire ai loro avversari ogni idolatria. Un autore serio non dovrebbe procedere in modo così acritico affidandosi a dati del tutto problematici e dubbi. Le conseguenze sono facilmente evidenti ove si confronti, come ho fatto io, con l’analisi dei testi originari.
Per chiudere definitivamente la questione ricordo, per chi conosce l’astrologia antica, che lo Khnoubis non poteva essere assolutamente un “simbolo del Cristo”, né per i Sethiani, né per gli Ofiti: lo Khnoubis raffigurato nelle gemme di quel periodo è infatti il simbolo di uno dei Decani, in particolare uno dei tre decani che reggono il segno del Cancro, e che – per corrispondenza microcosmica- governa il plesso epigastrico. Si usava apotropaicamente per curare le malattie di stomaco come ricorda il medico Marcello Empirico (V secolo). Gemme del genere erano incise sulle specifiche pietre, verdi nel caso del Cancro, e se ne rinvengono anche relative ad altri segni zodiacali. Cosicché si capisce che si tratta di un uso medico-magico. Ma in questa accezione lo Khnoubis è una Potenza minore, uno dei 36 decani e non può certo essere né il Sommo Arconte né il Christo Soter. In quanto potenza astrologica rappresenta sì per lo gnostico uno degli arconti cosmocratori, ma non si deve pensare che quella gemma fosse necessariamente un “simbolo gnostico”. Una cosa è la via mistica dello gnostico, altra cosa è l’uso magico – che chiunque poteva fare -di un simbolo, patrimonio comune delle conoscenze religiose e astrologiche dell’Egitto greco-romano. Il mago o il guaritore, per definizione, può fare “patti” e servirsi di Potenze per scopi mondani, Potenze che invece per lo gnostico devono essere vinte ma solo per “uscire dal Cerchio del Fato”.
In ogni caso, sia che fosse riferito a Yaldabaoth, sia che fosse riferito a Khnoubis, o altre potenze astrologiche minori, il serpente leontocefalo per gli gnostici non era oggetto di venerazione né simbolo di qualche cosmico Salvatore, bensì indicava un potere avverso.
Per comprendere il motivo del passaggio che ha portato a trasferire l’iconografia di uno dei decani nell’Arconte Yaldabaoth, una mia riflessione vorrebbe ricordare il Cancro quale “porta degli uomini”, legata al solstizio d’estate, inizio del ciclo discendente dell’anno e in relazione con la caduta, rispetto al Capricorno che è invece porta degli dei, la “via in su”, quale attestato sia da Porfirio (Antr. Nynpharum) che dalla Baghavad Gita (VIII, 24,25,26).
E’ allora possibile che la porta del Cancro, nel senso quindi di Janua Inferi , fosse particolarmente vista dallo gnostico come inizio della caduta cosmogonica e quindi, per metonimia, abbia indicato tutta l’opera degli Arconti in generale.
Per un’altra ricostruzione del passaggio da Knoubis a Yaldabaoth, leggasi:
Bollettino numismatico, monografia 8.2.I, 2003, Sylloge gemmarum gnosticarum, parte I pagg.78-80,opera di grandissima erudizione. L’autore, A. Mastrocinque, tenta una ricostruzione diversa dalla mia, ma molto interessante, anche se commette l’errore di attribuire quel simbolo a un decano del Leone. Egli comunque attribuisce le gemme di Khnoubis ai maghi egittizzanti politeisti, mentre ricorda come sia del tutto non provato che gli Gnostici creassero gemme di quel tipo, il che conferma quanto da me detto poco sopra circa la distinzione fra “uso magico” e “uso gnostico”.
Altre fonti per l’iconografia delle gemme gnostiche:
R.Halleux-J. Schamp Le lapidaires grecs, Paris, 1985.
B. De Rachewiltz Amuleti dell’Antico Egitto, Signa-tau, Roma, 1966 e J. Marquès-Rivière Amuleti, talismani e pantacoli, ed. Mediterranee, Roma, 2008.
F. Cumont, Les mystères de Sabazius et le judaïsme, in Compts rendus Ac. Inscript., 1903, p. 63 seg.; id., Les religions orientales dans le paganisme romain, 4ª ed., Parigi 1929.
Filed under: L'Uomo col Tabarro | Commenti disabilitati su Il Christo-Serpente. Cristianesimo e misteri antichi. Parte 1/ 2